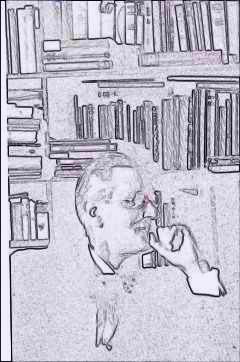Sparring partner al corso di editing della minimum fax

Ieri sono andato a fare lo sparring partner al corso di editing della minimum fax. Ero tutto fiero, vado lì, mi prendono a pugni il mio romanzo. Meno male che l’ho finito, se no magari mi arenavo, belin mi sembrava di essere sotto il fuoco di una mitragliatrice incarognita dello space invaders. Ora mi toccherà riscriverlo, il mio romanzo. Meno male che c’erano due o tre cose che gli piacevano a sti Atari di editor che mi hanno frantumato il romanzo.
Ero circondato da questo fuoco incrociato degli editor, che mi hanno rivoltato i primi tre capitoli del romanzo come le calze da stendere o i jeans prima di metterli in lavatrice. Lo sapevi che li devi rivoltare i jeans, vero? Se non lo sapevi adesso lo sai, che lo sporco è quello dentro mica fuori.
Comunque, bella esperienza. Pugni presi (molti) e dati, mi sembrava di essere uno di quei pugili alle prime armi, quando l’allenatore gli dice sali sul ring e prenditi un sacco di botte, però non cadere subito mi raccomando. Detto questo, penso che mi sia servito, anche perché ho imparato un sacco di cose che non sapevo sul mio romanzo.
La prima, non lo sapevo, la differenza fra io narrante e io narrato. Ne parlava l’editor di Forlì, quello con la barbetta, che ci ho messo un po’ a capire di cosa parlava. Vuol dire che mentre scrivi c’è un io, quello narrato, che è il protagonista e un altro io, che è sempre lo stesso, però fa il figo, che commenta quello che fa il protagonista. Insomma, c’è un io che fa minchiate e poi c’è un altro io che le commenta come se lui non c’entrasse niente. Il secondo io, quello narrante, è come la moviola, per capirsi, la moviola in campo.
Un’altra cosa che ho imparato e che non sapevo è che strizzo l’occhiolino al lettore. Non me l’ero data, adesso lo so. Vuol dire che scrivo delle cose paracule per compiacere il lettore. Non me n’ero accorto, nche perché di solito al lettore non è che ci penso mentre scrivo ma d’ora in poi ci penserò, che è meglio. Poi, ho imparato che le anguille sono viscide e le bisce no e che il Duplo non è il Kinder Bueno. Cazzo, come ho fatto a sbagliarmi non lo so nemmeno io.
Poi, random, ho imparato che in Inghilterra non c’è la subway ma la tube e non ci sono i cents ma i pence. Che se uno è nato in Uruguay ci deve essere per forza qualcosa dietro, soprattutto se ha sposato una polacca. Belin.
Altre cose che ho imparato dalle pulci che mi sono entrate nei primi tre capitoli del romanzo sono che se per caso o per culo ti entra una bella cosa nel tuo romanzo, allora tu devi sempre scrivere delle cose belle perché potenzialmente puoi. Come se uno fa un gol della madonna in partita, se poi non lo rifà allora è scarso perché il pubblico si aspetta sempre il numero.
Ho imparato che se parli una volta di un pizzaiolo non puoi riparlare di un altro pizzaiolo dopo, anche se uno è kosovaro e l’altro egiziano e vive a mille chilometrici distanza e che se voglio giocare con il lettore devo cambiare scherzi se no si rompe, povero lettore, e che le cose se le ripeti non va mica bene, devi inventartene di nuove e sugose tutto il tempo. Tipo, che se lavori in un posto fatto di amianto, se la volta dopo lavori di nuovo in un posto pieno di amianto non lo devi dire; devi cambiare materiale. Non so, devi dire che lavori in un posto fatto di polistirolo o di polimeri o di das o di pongo magari o di lego.
Ho imparato che càccara si scrive con l’accento sulla prima à, se no leggono caccàra e che probabilmente càccara è una parola che la capiscono in due o tre i Italia, compreso me e Gippi. Ho imparato che se parli di troie non devi farlo in generale, ma devi sempre specificare di che modello di troia si tratta. Vero. E che le virgole sono importanti. Non lo sapevo.
Non lo sapevo, ma ho imparato che quando scrivo le mie cose sto accompagnando il lettore da qualche parte e che mentre lo faccio devo stare attento alla grammatica e alle ripetizioni. Io pensavo di scrivere e basta, battere sulla tastiera, ma non è così, sto accompagnando qualcuno da qualche parte. Buono a sapersi, in effetti è così. Li ho portati tutti con me nel cesso, che poi volevano sapere com’è andata a finire con la vecchia quando ha messo la dieci cents, che però non va bene perché in Inghilterra ci sono i pence, ma questo l’ho già detto (ripetizione).
Ho sentito Nicola che diceva che la scrittura è un bastone immerso nell’acqua che si spezza (non l’acqua, editor, il bastone si spezza, ok?). Questa mi sembrava una bella immagine, del fatto che la scrittura non potrebbe mai essere una mappa 1:1 della realtà. Poi, un sacco di altre cose. Era divertente la storia del pacco. Per me un pacco è un pacco, per una editor, quella che mi ha prestato l’accendino, il pacco è un’altra cosa. Ma quello era divertente, vedi, pensavo di accompagnare gli editor nella mia storia e invece li ho accompagnati nella loro di storia personale, bella storia.
Ho imparato che tutti i personaggi del mio romanzo fanno schifo, sono distrutti dalla vita, che non ce n’è uno che si salva e che le donne del mio romanzo c’hanno tutte l’acne e la coprono con il fard. E’ vero. Ho imparato che parlare del Dalai Lama è scontato, che il Lupo della Steppa si è già sentito in giro e che Arbeit macht frei potevo evitarmelo e che Massimo Boldi e Sara Simeoni possono andare fuori dal mio romanzo.
Ho capito che questi editor si aspettavano uno diverso, forse credevano che io fossi quello del romanzo, uno spaccone. Ma non è così, io narrato io narrante. Il protagonista del mio romanzo è uno che ce l’ha con il mondo intero, se fossi come lui non potrei fare un passo fuori di casa senza prendermi una marea di legnate sulla faccia. Poi, ho imparato che anche lo sparring partner si deve mettere il casco quando sale sul ring, se no sono mazzate.
No, è stato bello stare sul ring con gli editor. Però a volte tenere il punto era difficile perché non è mica che lì, in due secondi, puoi trovare delle risposte lucide per cambiare delle robe che sono scritte nero su bianco e non è nemmeno che mentre scrivi ti domandi tutto il tempo perché lo sto scrivendo, è come se un cuoco si domandasse tutto il tempo perché sto cucinando. Perché sono capace, ti dirà il cuoco. Non penso che ti dirà perché i miei clienti hanno fame. Ma magari sì. Boh. Per scrivere devi startene da solo, solo soletto, davanti al tuo pc e magari chiamare lì di fianco io narrato che ti dà due dritte per non prenderti dei pugni sulla faccia e se rompe le palle chiamare il cazzo con gli stivali così io narrante la smette di fare il primo della classe, belin.
Però ala fine è stato bello, perché per una volta invece di tirare pugni al sacco li ho tirati e presi a mazzate con un bel gruppetto di editor e di editors. Poi ho imparato che i neologismi non vanno bene. Mi sa che l’editor come figura è uno molto importante per lo scrittore, perché gli fa da coscienza. Come un muro che ti rimbalza le minchiate che scrivi. E mi rendo conto che fare da coscienza critica a qualcuno è un compito difficile. Per esempio, a me mi piaceva quello che mi diceva la editor fiorentina, con gli occhiali, che era molto pacata e precisa.
Per il resto, penso che il mio romanzo sia molto piaciuto e mi fa piacere e se si sono fatti due ciocchi a leggerlo sono contento. Fra un po’ di tempo ci rimetterò le mani, adesso lo lascio un po’ decantare, come dice Christian. Ieri è stata una bella full immersion. La cosa strana era quando mi chiedevano, ma l’hai scritto apposta così? Ma ste ripetizioni le hai scritte volontariamente? Ma sto passaggio così pesante è voluto? Ma questo snodo perché l’hai liquidato così? Oh, belin, c’ho anche delle altre cose da fare, oltre a scrivere come un grafomane malato di tastiera. A parte lavorare, poi non so fare la spesa, guardarmi intorno e altre cose se no poi cosa scrivo?
Le cose che sono piaciute di più del mio romanzo sono state il cesso chimico, la tirata dei lavoratori, Kurt, la Guendy (quella me la sono totalmente inventata) e altre cose che non ricordo. Invece non gli piacciono i pacchetti preconfezionati e le soluzioni troppo facili oppure i riferimenti ai personaggi famosi. Buono a sapersi. Belin, mi toccherà farmi il culo, ma scusa l’editor non è che lo può scrivere lui il romanzo? No, stavo scherzando, piuttosto che farglielo scrivere all’editor belin mi metto in palestra come Rocky I (lo so che non dovrei scriverlo, che è scontato caga minchia di un editor). Allora cambio, come Raffo all’Audace, che mi sembra che assomigli un po’ al pizzaiolo kosovaro che parla swahili. Tiè.
Belin, non mi sono nemmeno potuto troppo concentrare sul fatto che c’erano delle belle editor, erano pugni in faccia appena mi distraevo un secondo. Ma il femminile di editor non esiste? Editrix? Ok, per me le editrix erano valide, solo che io l’occhiolino te lo dico non lo strizzo a nessuno al massimo mi strizzo i brufoli mi strizzo.
Ah, mi ero dimenticato una cosa. E’ vero, io sono un aspirante scrittore, aspirare aspiro di brutto, l’avevo già scritta sta cosa dell’aspira scrittori, e lo dicevo anche ieri, se ci sono degli editor che hanno voglia di continuare a editarmi soprattutto editrix che un occhio femminile magari non fa male, anche se l’editor più tignoso è quello che oggi è a Fano a farsi il bagno (beato lui) e quello più preciso, io sono contentissimo di prendemi ancora un bel po’ di botte da voi editors.
Leggi tutto